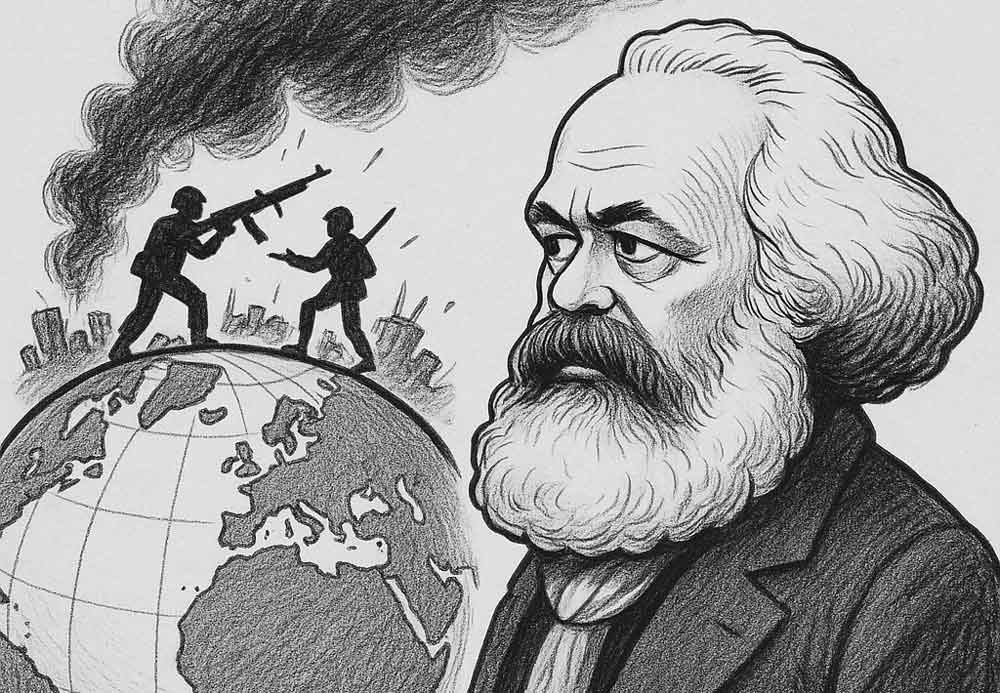Nel suo editoriale su Il Foglio, Andrea Graziosi si chiede perché in Italia Gaza mobiliti molto più di altre guerre urbane (da Grozny a Mariupol). La risposta, spiega, è stratificata: contano l’impatto delle immagini dei civili, la “catastrofe comunicativa” di Israele e la comunicazione efficace di Hamas, ma anche la scelta cruciale di Pd e Cgil di aderire formalmente alla mobilitazione, un caso raro per un partito già di governo nell’“Occidente”. A ciò si sommano i meccanismi dei social, il peso — carsico ma persistente — dell’antisemitismo europeo, e l’energia delle comunità immigrate nelle piazze.
Graziosi ricolloca Gaza dentro la storia lunga della guerra urbana: dalla Seconda guerra mondiale a Beirut e Hama, fino a Sarajevo, Grozny, Mosul/Raqqa e Mariupol. È un tipo di guerra che coinvolge inevitabilmente i civili e che, per questo, viene percepita come il “male assoluto”. Ma definire “genocidio” ogni strage di civili, osserva, confonde il senso giuridico del termine (l’eliminazione sistematica di una categoria) con i bombardamenti indiscriminati, come già accadde nel passato: una semplificazione che rischia di oscurare le categorie analitiche.
Perché allora guardiamo Gaza e non Grozny o Mariupol? Secondo l’autore, c’entra il declassamento europeo: in Medio Oriente ci si illude di “contare” ancora; guardando a Russia e Cina, invece, si percepisce l’impotenza e la sgradevole necessità di un riarmo. Conta poi una tradizione culturale della sinistra italiana: un lungo ’68 che ha trasmesso slogan e mentalità a generazioni successive, sostituendo talvolta l’ideale universalista con una lettura “popoli vs popoli”. Qui Graziosi vede il cedimento del centrosinistra a un “wokismo” poco originale e l’egemonia di forze estranee alla sua cultura riformista, con possibili costi elettorali e reputazionali.
Il punto più amaro, conclude, è vedere molti giovani in buona fede adottare schemi vecchi per un mondo nuovo e più duro: ciò che servirebbe è studiare la realtà per com’è, non rifugiarsi in categorie consolatorie — perché solo così si può affrontarne le sfide.
Fonte: Il Foglio Quotidiano, Andrea Graziosi, “L’Italia e Gaza. Una storia triste”, 8 ottobre 2025.
L'illustrazione utilizzata per questo articolo è generica e AI-generated; uso libero per finalità editoriali e commerciali.