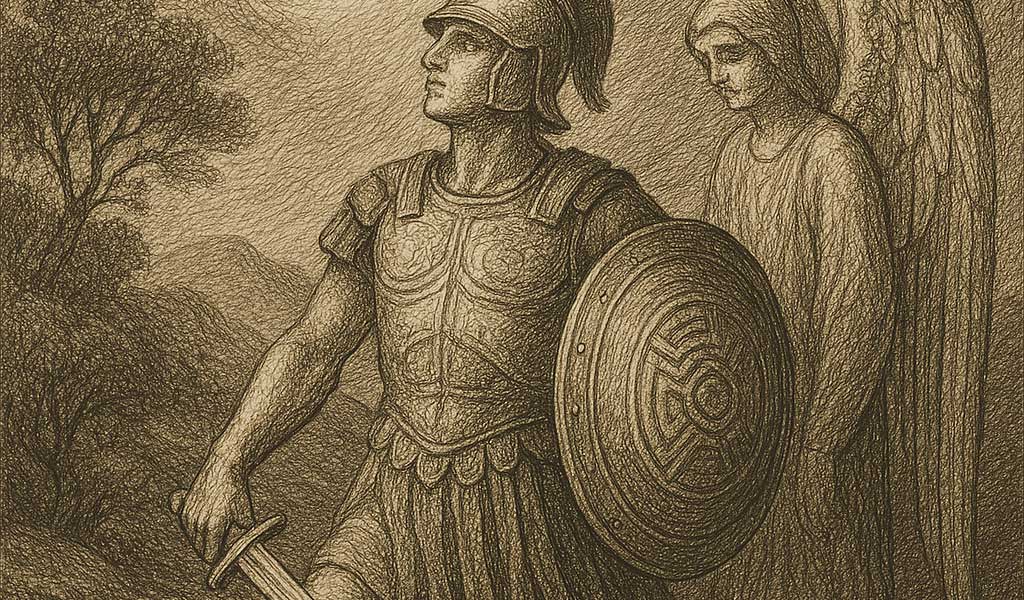Virginio Marzocchi osserva che, quando si parla di mondo greco-antico, in particolare di quello «classico», cioè riferibile ai secoli V-IV a.C., si fa riferimento soprattutto a quell’insieme di città chiamate pòleis (singolare pòlis), dotate di un territorio agricolo circostante più o meno esteso, distribuite non solo nella penisola greca, ma anche lungo le coste del Mar Nero e del Mar Mediterraneo.
Egli afferma in che questo mondo greco-antico classico da un lato assiste alla fine della rilevanza della pòlis, e dall’altro si espande ancora, soprattutto dal punto di vista linguistico e culturale, grazie alle conquiste di Alessandro Magno, re macedone, che fino al 323 a.C. (anno della sua morte) sottomette l’Impero Egiziano e quello Persiano. Marzocchi precisa che nel periodo «ellenistico», che segue la morte di Alessandro, il mondo greco si stabilisce in modo duraturo in Asia Minore, Siria ed Egitto, mantenendo la propria influenza anche dopo le conquiste romane di quei territori, a partire dal I secolo a.C.
Egli sottolinea che sono stati i tragici — tra cui cita Eschilo con la trilogia Orestea e Sofocle con la Antigone — insieme agli storici, come b (autore delle Storie) e Tucidide (autore de La guerra del Peloponneso), a gettare le basi per il pensiero dei grandi filosofi Platone e Aristotele.
Secondo Marzocchi, i primi, cioè tragici e storici, mostrano un’attenzione e una simpatia per la democrazia maggiori rispetto a quelle manifestate successivamente dai filosofi.
Egli sostiene che esiste comunque un tratto comune a tutti questi autori. Tale tratto è connesso anche all’esperienza delle due guerre vinte contro l’Impero Persiano, una potenza in espansione dotata di forze e mezzi ben superiori a quelli delle pòleis greche. Questo elemento comune consiste nella convinzione che l’unico regime veramente politico, adatto cioè alla pòlis greca, sia un governo esercitato secondo leggi su cittadini liberi e consenzienti. Marzocchi specifica che tale governo deve derivare da una ponderata considerazione delle diverse componenti della città e delle loro molteplici esigenze. Al contrario, egli rileva come venga contrapposto a questo modello politico il potere fondato sulla volontà arbitraria di imporsi, definito «tirannide», che viene considerato non-politico in quanto distruttivo dell’unità rappresentata dalla pòlis, e perciò bollato come barbaro, non-greco, straniero, orientale.
Marzocchi sostiene che è proprio l’enfasi posta sul momento deliberativo e ponderativo, fondato su cognizioni, a rendere possibile l’ingresso del pensiero filosofico nel discorso politico.
Tuttavia, egli invita a non dimenticare che l’unità rappresentata dalla pòlis — da cui deriva il termine «politica» — così come quelle unità simili che la seguiranno, come la civitas romana (da cui deriva «civile») o la comunale medievale, sono realtà geograficamente e storicamente limitate. Marzocchi sottolinea che, se si confrontano con entità molto più estese nel tempo e nello spazio — che oggi chiamiamo imperi e che pure definiamo politici —, tali unità risultano minoritarie. Egli menziona, oltre all’Impero Persiano e a quello Macedone di Alessandro Magno, anche gli imperi dell’Egitto, della Mesopotamia (assira e babilonese), dell’India e della Cina, oltre naturalmente all’Impero Romano (da Augusto fino al 476 d.C. in Occidente e al 1453 in Oriente) e al Sacro Romano Impero, nato con l’incoronazione di Carlo Magno nell’800 d.C.
Riferimento bibliografico:
Virginio Marzocchi. Filosofia politica. Storia, concetti, contesti. Laterza