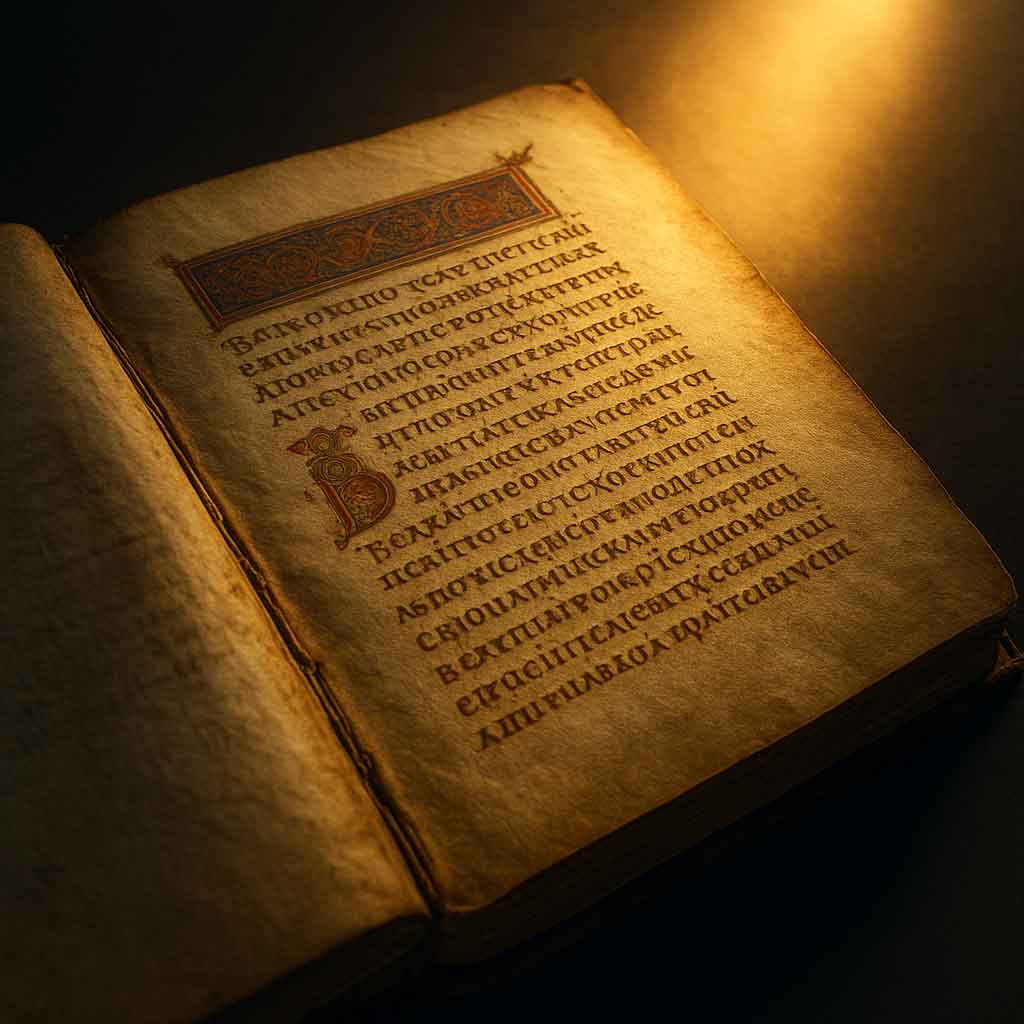Luciano Canfora, nella sua lezione per il Corriere della Sera, invita a leggere il Nuovo Testamento non come un testo sacro intoccabile, ma come un’opera di enorme rilievo letterario e storico, raramente conosciuta davvero da chi la venera. L’autore parte dal titolo stesso: perché “nuovo”? L’aggettivo, osserva, implica un confronto e perfino un progresso rispetto all’“antico”, cioè all’ebraismo e al Pentateuco. Ma questa contrapposizione non è solo terminologica: è il segno di un rapporto complesso tra due monoteismi legati e insieme divisi, la religione ebraica e quella cristiana.
La tradizione cristiana, nata in ambiente greco, si è appropriata del testo ebraico traducendolo e diffondendolo nel mondo ellenofono, specialmente in Egitto. Così l’Antico e il Nuovo Testamento si sono saldati in un unico libro, che tuttavia nasconde al suo interno due universi diversi per lingua, tono e visione.
Canfora ricorda che il Nuovo Testamento comprende i quattro Vangeli (tre “sinottici” e quello di Giovanni), gli Atti degli Apostoli, le lettere paoline e canoniche, e l’Apocalisse — quest’ultima, a lungo contestata prima di entrare nel canone. Dal punto di vista stilistico, nota il filologo, il Vangelo di Luca è il più raffinato, mentre Matteo conserva tracce di una traduzione più popolare dal linguaggio ebraico originario.
I testi, pur riferendosi agli anni 25-30 dell’era volgare, vengono redatti decenni dopo, in ambienti greco-egiziani dove la nuova fede si sta diffondendo con forza. Già intorno al 110-120 d.C. esiste un papiro contenente frammenti di un Vangelo: una prova che la tradizione scritta nasce presto e si consolida grazie alla spinta missionaria di Paolo, figura politicamente aggressiva e decisiva per la costruzione del canone.
Colpisce, osserva Canfora, che i papiri del Nuovo Testamento siano quasi numerosi quanto quelli di Omero: segno di una fede che si è diffusa nell’intero Mediterraneo. Ma non si trattava di un messaggio rassicurante: era una religione universale e “sovversiva”.
Canfora lo mostra confrontando due versioni delle Beatitudini. Luca scrive “Beati i poveri, perché vostro è il regno dei cieli”, mentre Matteo addolcisce in “Beati i poveri di spirito”. La seconda formula, più conciliatoria, attenua la forza sociale della prima, che dava ai poveri la rivincita in un aldilà di giustizia. È questo il senso della “religione di salvezza”: un testo di lotta, di rovesciamento dei valori dominanti.
Allo stesso modo, l’episodio dell’adultera – con Gesù che disarma l’ipocrisia dei moralisti pronunciando “Chi è senza peccato scagli la prima pietra” – rivela la carica rivoluzionaria del messaggio evangelico: un attacco al perbenismo, una lezione di compassione e autocritica che attraversa i secoli.
Il Nuovo Testamento, conclude Canfora, è dunque un insieme di testi che non smette di sorprendere: venerato, ma poco letto; antico, ma ancora capace di inquietare e di interrogare le coscienze.
Fonte: Luciano Canfora, Il Nuovo Testamento, in Le lezioni del Corriere, Corriere della Sera, 17 maggio 2025.
L'illustrazione utilizzata per questo articolo è generica e AI-generated; uso libero per finalità editoriali e commerciali.