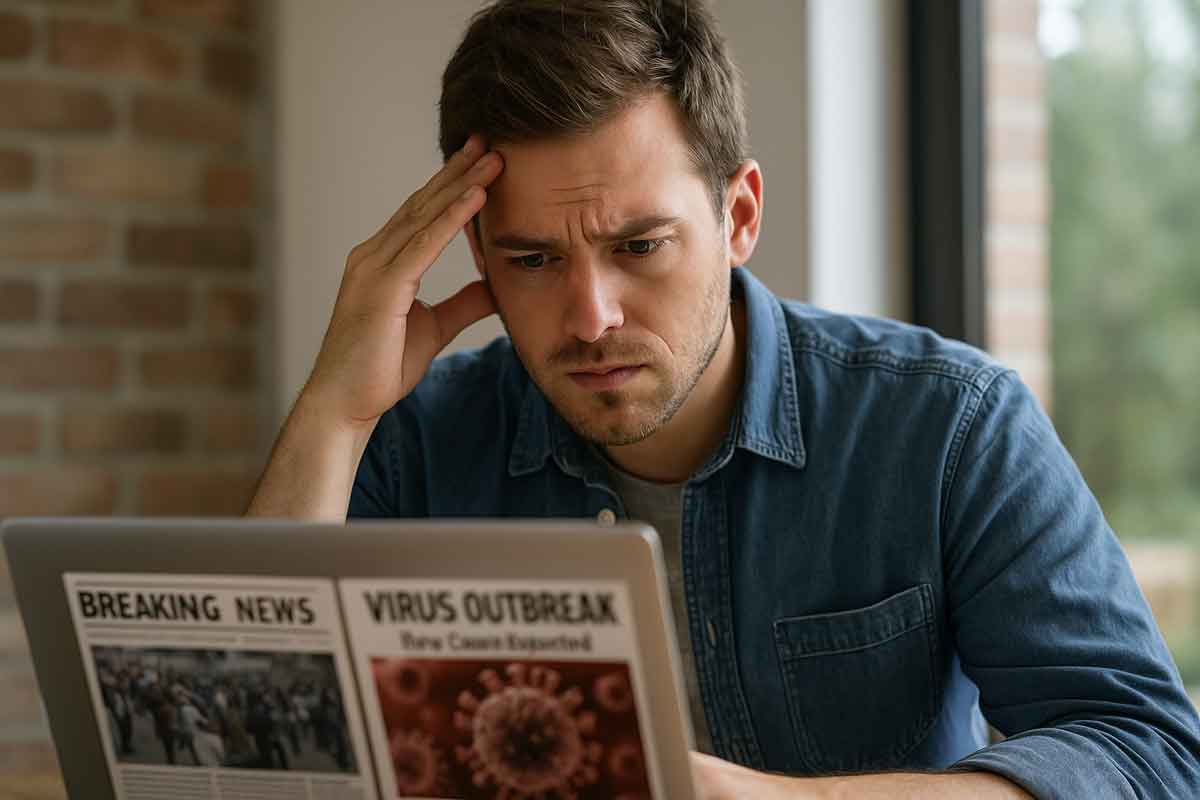Immaginiamo di svegliarci leggendo di una pericolosa influenza che si sta diffondendo nella nostra città. Le autorità sanitarie minimizzano, ma i social media esplodono di opinioni contrastanti, tra presunti esperti che discutono l’origine e la letalità del virus. Gli ospedali si riempiono, il panico ostacola le cure per altri pazienti e iniziano a verificarsi decessi. Solo in seguito si scopre che tutto è stato orchestrato da una potenza straniera, tramite informazioni false fatte circolare ad arte. Eppure, nulla in questo scenario rientra nelle definizioni attuali di “atto di guerra”.
È questo il cuore della “cognitive warfare” (guerra cognitiva), una strategia che punta a influenzare percezioni, emozioni e comportamenti, senza bisogno di colpire fisicamente l’avversario. Secondo David Gisselsson Nord, docente all’Università di Lund, si tratta di un nuovo campo di battaglia: la mente umana, dove la guerra si combatte non più con le armi ma con le idee, le emozioni e la disinformazione.
Un esempio classico di guerra cognitiva è il “controllo riflessivo”, perfezionato dalla Russia nel corso dei decenni. Questo metodo consiste nel modellare le percezioni dell’avversario affinché agisca secondo i desideri di chi lo manipola, senza accorgersene. Nella guerra in Ucraina, questo approccio si è tradotto in narrazioni mirate: rivendicazioni storiche sui territori ucraini o descrizioni dell’Occidente come corrotto moralmente.
Il vero scopo della guerra cognitiva, spiega Gisselsson Nord, è modificare la percezione della realtà. Grazie alla rivoluzione digitale, è oggi possibile agire in modo mirato sulla base delle tracce lasciate online dagli utenti, con tecniche di microtargeting che impiegano intelligenze artificiali per diffondere contenuti capaci di rafforzare bias cognitivi e convinzioni pregresse. Non servono più video o fotografie: basta un prompt ben calibrato per inserire false narrazioni nel flusso informativo quotidiano.
I confini tra manipolazione cognitiva e danno fisico diventano così sempre più sfumati. Durante la pandemia da COVID-19, la disinformazione ha provocato decessi tra chi rifiutava le misure sanitarie o si affidava a cure pericolose. Alcuni di questi messaggi erano parte di operazioni di guerra dell’informazione, sostenute da Stati come Russia e Cina tramite profili generati dall’IA.
La prospettiva è inquietante. Le tecnologie di interfaccia cervello-macchina, come quelle sperimentate dal programma N3 della DARPA, potrebbero un giorno collegare direttamente i pensieri umani al mondo digitale. Se questi sistemi fossero manipolati o “avvelenati” con dati ingannevoli, il confine tra la sfera informativa e quella biologica risulterebbe definitivamente superato.
Il problema, osserva l’autore, è che la guerra cognitiva non trova posto nelle attuali norme del diritto internazionale. Le leggi sui conflitti armati si basano sull’uso della forza fisica. Ma una strategia che mira a provocare panico e morte attraverso la manipolazione mentale, può davvero non essere considerata una minaccia? E se un programma sanitario venisse usato per raccogliere DNA a scopi militari, tradendo la fiducia dei cittadini, si tratterebbe di un’inganno vietato (perfidy) o solo di un “inganno lecito” in guerra?
Per affrontare queste sfide, secondo Gisselsson Nord, è necessario innanzitutto aggiornare la nostra idea di “minaccia”. L’articolo 2.4 della Carta dell’ONU vieta le minacce di forza, ma si tratta pur sempre di un paradigma fisico. È ora di considerare anche le minacce cognitive come forme di aggressione. Inoltre, il danno psicologico andrebbe riconosciuto come danno a tutti gli effetti, così come già accade per il disturbo da stress post-traumatico nei reduci di guerra.
Infine, forse è il momento di guardare oltre il diritto bellico tradizionale. Le tutele dei diritti umani – come la libertà di pensiero e d’opinione o il divieto di propaganda bellica – potrebbero offrire strumenti per proteggere le società civili da questi attacchi invisibili ma devastanti. Perché la guerra del futuro, conclude Gisselsson Nord, sarà combattuta nelle menti delle persone, e solo una società consapevole e legalmente preparata potrà difendersi.
Fonte: David Gisselsson Nord, “Cognitive warfare: why wars without bombs or bullets are a legal blind spot”, The Conversation, 18 luglio 2025
L'illustrazione utilizzata per questo articolo è generica e AI-generated; uso libero per finalità editoriali e commerciali.