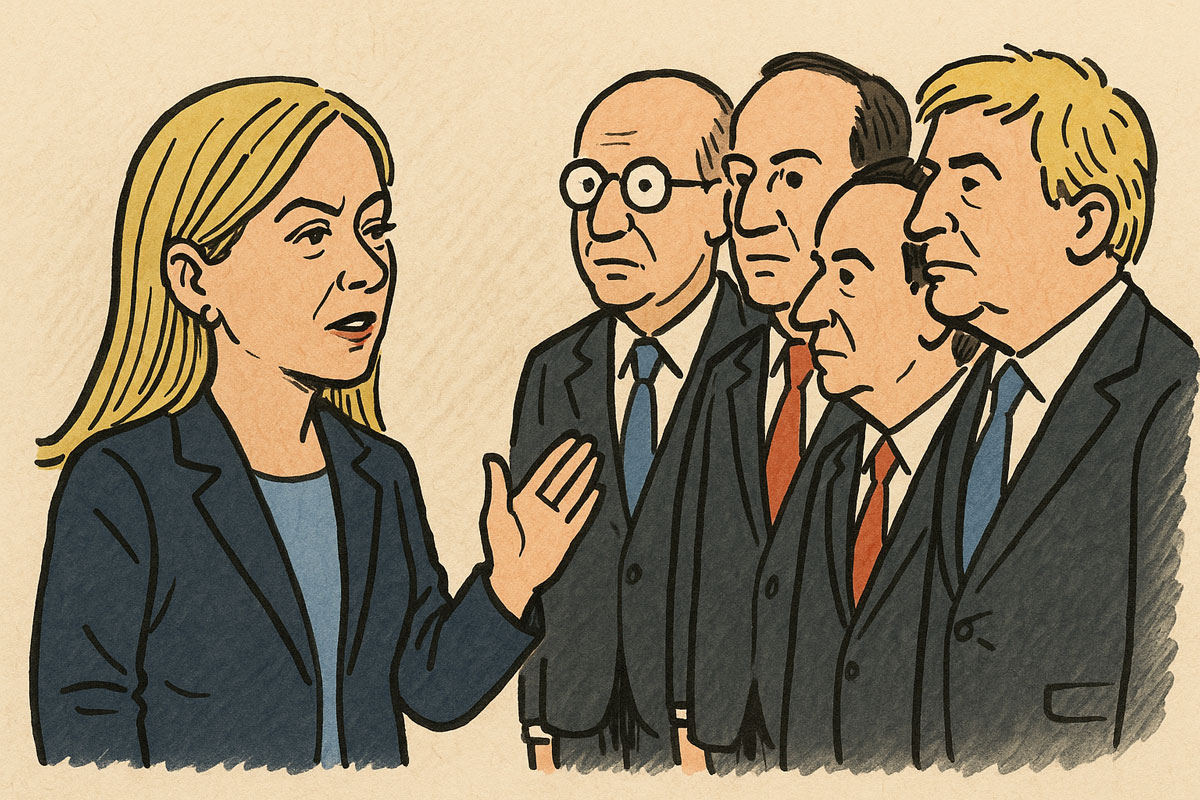La forma del potere che oggi domina l’Italia reca il volto di una donna: Giorgia Meloni. Il mio interesse, da sociologo, non è lodare né biasimare, bensì comprendere il tipo di legittimità che la sorregge e le prove che la attendono. Nel ciclo 2018‑2022 Meloni si è costruita come leader carismatica di un’opposizione identitaria capace di parlare alle masse disorientate dalla pandemia; la vittoria alle politiche del 2022 e, soprattutto, il 28,9 % conseguito alle europee 2024 – con un’affluenza crollata al 49,6 % – hanno sancito la trasformazione di quel carisma in potere di governo . Ma il carisma, per durare, deve farsi burocrazia, procedura, routine: in una parola, legalità razionale.
È in quest’ottica che va letta la scelta – irrituale per un partito «sovranista» – di rispettare i vincoli europei sul PNRR e di spingere la spesa per la difesa fino al 2 % del PIL, obiettivo annunciato per quest’anno . È qui che l’etica della responsabilità, inevitabile per chi governa, argina gli slanci dell’etica della convinzione che animava l’opposizione: l’ideale deve misurarsi con i conti pubblici e con l’alleanza atlantica.
Tuttavia la premier continua a cercare una legittimazione plebiscitaria diretta: la centralità dei social, le dirette streaming dei question time, la riduzione del Parlamento a palcoscenico testimoniano la volontà di un contatto costante fra leader e popolo che aggira le mediazioni partitiche. Il rischio è evidente: se la partecipazione elettorale ristagna, il plebiscito permanente può trasformarsi in monologo.
All’estero Meloni pratica un carisma pragmatico. Al vertice sull’Ucraina ha invocato un cessate‑il‑fuoco di trenta giorni, presentandosi come mediatrice fra Washington, Ankara e Kyiv . Eppure, nel foro europeo, l’autoproclamata «stabilità» italiana incontra diffidenze: i conti restano fragili, il debito sfiora il 135 % del PIL e l’aumento delle spese militari inquieta i mercati .
Questa oscillazione fra convinzione e responsabilità non è incoerenza, ma il destino di ogni politico moderno: chi fa politica «con la passione e al tempo stesso con il distacco degli occhi della mente» deve congiungere ideale e calcolo. Il prossimo autunno la legge di bilancio mostrerà se la premier saprà conciliare l’impegno atlantico con i salari reali fermi da vent’anni; ugualmente decisivi saranno l’istituzionalizzazione del suo partito, per ora leader‑centrico, e la capacità di incidere in un’Unione europea che premia la pazienza negoziale più del fervore oratorio.
Concludendo, ricordo ciò che in Politik als Beruf chiamai «il demone freddo della politica»: chi aspira a governare deve servire un dio diverso dall’entusiasmo romantico, un dio che chiede di calcolare le conseguenze delle proprie decisioni sul destino comune. Alla premier Meloni – e all’Italia che in lei si riconosce – spetta decidere se il carisma resterà fuoco d’artificio o si muterà in fiamma durevole, temperando l’acciaio di una democrazia matura. Per ora la bilancia resta in equilibrio: un passo falso, e la grazia carismatica può dissolversi con la stessa rapidità con cui è sorta; un passo ponderato, e quel carisma potrà solidificarsi in leadership costituzionale, contribuendo alla difficile arte di governare un Paese la cui passione politica è intensa quanto la sua sfiducia nelle istituzioni.
Max Weber per Teorie Politiche
L'illustrazione utilizzata per questo articolo è generica e AI-generated; uso libero per finalità editoriali e commerciali.